Il vestito rosso
di Alice Munro
Mia madre mi stava facendo un vestito. Per tutto il mese di novembre, tornando da scuola, la trovavo in cucina, circondata da tagli di velluto rosso e modelli di carta velina.
Lavorava su una vecchia macchina a pedale accostata alla finestra per vederci meglio, ma anche per guardare fuori, oltre i campi di stoppie e gli orti spogli, e vedere chi passava per la strada. Raramente passava qualcuno.
Il velluto era una stoffa – difficile da cucire, tirava; mia madre, inoltre, aveva scelto un modello complicato. Non era una sarta molto abile. Le piaceva confezionare vestiti, il che è diverso. Cercava di evitare i lavori come imbastire e stirare e a differenza di mia zia e mia nonna non andava affatto fiera di quelle che sono le finezze della sartoria, come la rifinitura delle asole e il sopraffilo delle cuciture. Lei partiva con un’ispirazione, un’idea fastosa e abbagliante; da quel momento in poi,il piacere andava scemando. Per cominciare, non riusciva mai a trovare un modello che la soddisfacesse. Non c’era da meravigliarsi: non esistevano modelli che corrispondessero alle idee che sbocciavano nella sua testa. Nel corso degli anni mi aveva fatto: un vestito di organza a fiori accollato, con un colletto di pizzo che mi dava prurito e un cappello uguale a larghe tese; un completo scozzese con una giacca di velluto e un berretto anch’esso scozzese; una camicetta ricamata con le maniche a sbuffo da portare con un’ampia gonna rossa ed un corpino nero ornato di merletti. Ai tempi in cui ero ignara del giudizio del mondo portavo questi abiti con docilità, anche con piacere. Ora che mi ero fatta più avveduta, desideravo vestiti come quelli che la mia amica Lonnie acquistava al negozio di Beale.
Dovevo provarlo. A volte Lonnie veniva a casa con me dopo la scuola e si sedeva sul divano a osservare le prove. Mi imbarazzava il modo in cui mia madre mi girava furtivamente intorno, le ginocchia scricchiolanti, il respiro affannoso. Parlottava tra sé e sé. Quando era in casa non portava corsetto né calze, ma scarpe con la zeppa e calzini alla caviglia; aveva le gambe solcate da vene sporgenti verdeazzurre. Mi sembrava volgare in quella posizione accoccolata, quasi oscena; cercavo di parlare a Lonnie in continuazione, per distogliere la sua attenzione quanto più possibile da mia madre. Lonnie aveva dipinta in viso quella sua espressione educata, composta, piena di stima che costituiva il suo travestimento in presenza di adulti. In loro assenza, rideva di loro e li scimmiottava ferocemente, e nessuno lo veniva mai a sapere.
Mia madre mi strattonava a destra e a manca riempiendomi di spilli. Mi faceva voltare, allontanare, stare ferma immobile. « Che cosa ne dici, Lonnie? » chiedeva con la bocca piena di spilli. « È bellissimo » rispondeva Lonnie in tono pacato e sincero. La madre di Lonnie era morta. Lei viveva con suo padre che non si accorgeva neppure della sua presenza, e questa circostanza, ai miei occhi, la rendeva al tempo stesso vulnerabile e privilegiata.
« Sarà bellissimo, se riesco ad azzeccare la misura » replicava mia madre. « Mah, » diceva poi in tono enfatico, raddrizzandosi in mezzo a un deprecabile concerto di sospiri e scricchiolii, « chissà se lo apprezza ». Mi faceva rabbia quando parlava in quel tono con Lonnie, come se lei fosse adulta e io ancora una bambina. « Sta ferma » diceva, sfilandomi il vestito imbastito e pieno di spilli dalla testa. Avevo la testa avvolta dal velluto, il corpo esposto, coperto soltanto da una vecchia sottoveste di cotone di quelle che usavo per andare a scuola. Mi
sentivo come un grosso ammasso di carne cruda, goffa e con la pelle d’oca. Avrei voluto essere come Lonnie, con le ossa sottili, pallida e magra; era nata cianotica.
« A me nessuno mi faceva i vestiti quando andavo alle superiori » disse mia madre. «Me li facevo da sola, oppure ne facevo a meno. » Temevo che avrebbe ricominciato con la solita solfa di quando doveva farsi dieci chilometri a piedi per andare in città e si era dovuta trovare un lavoro come cameriera in una pensione per pagarsi la scuola. Tutte le storie sulla vita di mia madre, che un tempo trovavo interessanti, avevano cominciato ad apparirmi melodrammatiche, insignificanti e noiose.
« Una volta mi regalarono un vestito » disse. «Era di cachemire bianco panna con i bordi blu oltremare e degli splendidi bottoni di madreperla. Mi chiedo che fine avrà fatto. »
Quando ci liberavamo Lonnie ed io salivamo in camera mia. Faceva freddo, ma stavamo lassù. Parlavamo dei ragazzi della nostra classe e procedendo con ordine ci chiedevamo a vicenda, «Ti piace? Ti piace un pochettino? Lo detesti? Usciresti con lui se te lo chiedesse? » Nessuno ce lo aveva mai chiesto. Avevamo tredici anni e avevamo cominciato le superiori da due mesi. Facevamo i test delle riviste per scoprire se avevamo personalità e se saremmo state ragazze richieste. Leggevamo articoli che spiegavano come truccarsi per mettere in risalto i punti forti, come condurre una conversazione al primo appuntamento e che cosa fare quando un ragazzo cercava di spingersi troppo in là. Leggevamo anche articoli sulla frigidità in menopausa, sull’aborto e sui motivi che spingono i mariti a cercare distrazioni fuori casa. Quando non eravamo a occupate con i compiti, passavamo la maggior parte del tempo a discutere informazioni sul sesso. Avevamo fatto il patto di dirci tutto. Ma c’era una cosa che non le avevo detto: il ballo di Natale della scuola, per il quale mia madre mi stava facendo un vestito. Non gliel’avevo detto detto perché non ci volevo andare.
A scuola non mi sentivo mai a mio agio, neppure per un minuto. Non so Lonnie. Prima di un esame, lei aveva le mani gelate e le palpitazioni, ma io ero prossima alla disperazione in ogni momento. Quando in classe mi rivolgevano una domanda, una semplice domandina qualsiasi, mi usciva una voce stridula, oppure rauca e tremante. Quando mi chiamavano alla lavagna ero sicura di avere la gonna macchiata di sangue – anche in periodi del mese in cui non poteva essere. Quando dovevo adoperare il compasso alla lavagna, le mani mi sudavano. Non riuscivo mai a prendere la palla quando si giocava a pallavolo; dover fare qualcosa davanti agli altri faceva venire meno tutti i miei riflessi. Odiavo pratica aziendale, perché dovevamo tracciare delle righe sui registri contabili e quando l’insegnante veniva a controllare il mio lavoro mi venivano fuori delle righe tutte storte e tremolanti. Odiavo le scienze: stavamo appollaiati sugli sgabelli sotto luci sgradevoli, davanti a tavoli carichi di strane, fragili attrezzature e il nostro insegnante era il preside della scuola, un uomo dalla voce fredda e compiaciuta – tutte le mattine leggeva le sacre scritture – e un grande talento per infliggere umiliazioni. Odiavo la letteratura perché i ragazzi giocavano a tombola in fondo all’aula mentre l’insegnante, una ragazza corpulenta e gentile, lievemente strabica, leggeva Wordsworth. Lei li minacciava, li supplicava, il viso rosso e una voce altrettanto priva di efficacia quanto la mia. I ragazzi si scusavano con fare burlesco e quando lei riprendeva a leggere assumevano un atteggiamento rapito, ostentavano espressioni estatiche, incrociavano gli occhi e si portavano le mani al cuore. A volte l’insegnante scoppiava a piangere, non poteva farci nulla, doveva scappare fuori. Allora i ragazzi iniziavano a muggire rumorosamente; le nostre risate fameliche – oh, anche le mie – la inseguivano fino in corridoio. In quei momenti regnava nell’aula un’atmosfera carnevalesca e brutale, che spaventava le persone deboli e sospette come me.
Ma quello che accadeva in realtà a scuola non aveva nulla a che vedere con pratica aziendale, scienze, o inglese: era qualcos’altro a dare alla vita la sua smania e vivacità. Quel vecchio edificio, con il suo seminterrato umido di pietre nude, i guardaroba oscuri e i quadri di regnanti morti ed esploratori dispersi, era pregno della tensione e dell’eccitazione della competizione sessuale; e nonostante i sogni ad occhi aperti di strepitosi successi, avevo il presentimento di una totale sconfitta. Doveva accadere qualcosa che mi tenesse lontana da quel ballo.
Con dicembre venne la neve ed ebbi un’idea. Avevo già preso in considerazione di cadere dalla bicicletta e storcermi una caviglia, e ci avevo anche provato, tornando a casa per quelle strade di campagna gelate e piene di solchi profondi.
Ma era troppo difficile, tuttavia, ero debole di gola e di bronchi: perché non cercare di ammalarmi? Cominciai ad alzarmi di notte e aprire un poco la finestra. Mi inginocchiavo e lasciavo che il vento, a volte misto a un nevischio pungente, furoreggiasse intorno alla mia gola scoperta. Mi toglievo la giacca del pigiama. “Blu dal freddo” mi dicevo, mentre in ginocchio, gli occhi chiusi, immaginavo che il petto e la gola mi diventassero blu, di quel blu freddo e grigiastro che hanno le vene sotto la pelle. Rimanevo così finché non resistevo più, poi prendevo una manciata di neve dal davanzale e me la spalmavo su tutto il petto, prima di riabbottonarmi il pigiama. La neve si sarebbe sciolta al contatto con la flanella e io avrei dormito con il pigiama bagnato, la cosa peggiore che si potesse fare. Al mattino, appena sveglia, mi raschiavo la gola per vedere se mi facesse male, tossivo un paio di volte a titolo di prova, piena di speranza, mi toccavo la fronte per vedere se avevo la febbre. Tutto inutile. Tutte le mattine, compreso il giorno del ballo, mi alzavo sconfitta, in perfetta salute.
Il giorno del ballo mi arricciai i capelli con bigodini di metallo. Non l’avevo mai fatto, perché avevo i capelli naturalmente ricci, ma quel giorno avevo bisogno della protezione di tutti i possibili rituali femminili. Stavo sdraiata sul divano della cucina, leggendo Gli ultimi giorni di Pompei e desiderando essere laggiù. Mia madre, mai contenta, stava cucendo un colletto di pizzo bianco sul vestito: aveva deciso che, senza, l’abito sarebbe risultato troppo da adulta. Guardavo l’orologio. Era uno dei giorni più corti dell’anno. Sopra il divano, sulla carta da parati, c’erano le tracce di vecchie partite a tris, disegni e scarabocchi che mio fratello ed io avevamo fatto quando eravamo costretti a casa con la bronchite. Guardandoli, desideravo ardentemente poter ritornare al sicuro dentro i confini dell’infanzia.
Quando mi tolsi i bigodini, i capelli, sia per loro natura, sia per lo stimolo artificiale, saltarono in tutte le direzioni in un esuberante cespuglio lucido. Li bagnai, li pettinai, li frustai con la spazzola e me li tirai con forza lungo le guance. Mi misi la cipria: sul mio viso accaldato, sembrava gesso. Mia madre tirò fuori la sua acqua di Colonia, che non usava mai, e mi permise di spruzzarmela sulle braccia. Poi mi chiuse la cerniera del vestito e mi fece voltare verso lo specchio. Era un abito stile princesse, con un corpino molto aderente. Vidi i miei seni, nel loro nuovo reggipetto rigido, risaltare in modo sorprendente, con matura autorevolezza, sotto i fronzoli infantili del colletto.
« Oh, quanto mi piacerebbe farti una foto! » disse mia madre. « Sono proprio orgogliosa di quel vestito. E potresti anche dirmi grazie. »
« Grazie » dissi.
La prima cosa che disse Lonnie quando le aprii la porta fu: « Gesù, che cosa ti sei fatta ai capelli? »
« Ho messo i bigodini. »
« Sembri una zulù. Oh, non ti preoccupare. Prendi un pettine, ché ti piego la frangia in sotto. Ti starà bene, ti farà anche sembrare più grande. »
Sedetti di fronte allo specchio mentre Lonnie, in piedi alle mie spalle, mi aggiustava i capelli. Mia madre sembrava incapace di lasciarci sole. Avrei voluto che lo facesse. Guardava i miei capelli prendere forma e diceva: « Sei bravissima, Lonnie. Dovresti fare la parrucchiera »
« È un’idea » rispose Lonnie. Indossava un vestito di crespo celeste, con una fascia e un fiocco in vita; era molto più da adulta del mio, anche senza colletto. Era riuscita a farsi i capelli lisci come quelli della ragazza sulla confezione delle forcine. Avevo sempre segretamente pensato che Lonnie non potesse essere carina perché aveva i denti storti, ma ora capivo che, denti storti o no, il suo vestito alla moda e i suoi capelli lisci mi facevano assomigliare un po’ a uno spaventapasseri, infagottata nel velluto rosso, i capelli in tutte le direzioni, un accenno di delirio negli occhi sgranati.
Mia madre ci accompagnò alla porta e ci gridò nel buio: « Au reservoir! » Era un gioco tra Lonnie e me; in bocca a mia madre, il saluto risultava sciocco e squallido ed ero così arrabbiata perché l’aveva usato che non risposi. Soltanto Lonnie rispose allegramente, in tono incoraggiante: « Buona notte! »
La palestra della scuola odorava di pino e di cedro. Campane rosse e verdi di carta crespa erano appese ai canestri del basket; le alte finestre munite di sbarre erano nascoste da rami verdi. Alcune delle ragazze del quarto e del quinto anno avevano portato ragazzi già diplomati, giovani uomini d’affari. Questi giovanotti fumavano nella palestra, nessuno poteva impedirglielo, erano liberi. Le ragazze stavano al loro fianco, la mano abbandonata con noncuranza su una manica maschile, i visi annoiati, distaccati e belli. Avrei voluto essere come loro. Si come se soltanto loro, le più grandi, fossero al ballo, come se le ragazze più piccole, tra cui si aggiravano guardandosi intorno, fossero, se non invisibili, inanimate; quando fu annunciato il primo ballo – una canzone di Paul Jones – si avviarono verso la pista con movimenti languidi, sorridendosi l’un l’altra come se le avessero invitate a partecipare a qualche gioco infantile ormai quasi dimenticato. Tenendoci tremanti per mano, tutte ammassate, Lonnie ed io e le altre ragazze del primo anno le seguimmo.
Non osavo guardare le mie compagne quando mi passavano accanto, per timore di vederle affrettarsi in modo poco educato. Quando la musica finì rimasi dov’ero e, alzando appena gli occhi da terra, vidi un ragazzo di nome Mason Williams dirigersi con aria riluttante verso di me. Sfiorandomi appena la vita e la mano, si mise a ballare con me. Avevo le gambe molli, il braccio mi tremava tutto e non sarei riuscita a dire una parola. Questo Mason Williams era uno degli eroi della scuola: giocava a basket e a hockey e girava per i corridoi con un’aria da principe scontroso, intrisa di barbaro sdegno. Dovere ballare con una nullità come me era altrettanto offensivo per lui che dovere imparare a memoria un brano di Shakespeare. Avvertivo tutto questo con la stessa chiarezza con cui doveva avvertirlo lui e immaginai che si stesse scambiando occhiate disperate con i suoi amici. Mi guidò inciampando verso il margine della pista. Mi tolse la mano dalla vita e lasciò cadere il mio braccio.
« Ci vediamo » disse e se ne andò.
Ci misi un minuto o due a rendermi conto di ciò che era accaduto e a capire che non sarebbe tornato. Andai verso la parete e rimasi lì in piedi da sola. L’insegnante di educazione fisica, di passaggio mentre danzava energicamente tra le braccia di un ragazzo di seconda, mi lanciò un’occhiata indagatrice. Era l’unica insegnante della scuola che si servisse dell’espressione “socializzare” e temevo che avesse assistito alla scena, o che scoprisse che cosa era accaduto, e facesse qualche orribile tentativo pubblico per costringere Mason a terminare il ballo con me. Io non ero arrabbiata con Mason, o sorpresa: accettavo la sua posizione, e la mia, nel mondo della scuola e capivo che ciò che aveva fatto era la cosa più realistica da fare. Lui era un Eroe Naturale, non un eroe del tipo Rappresentante degli Studenti, destinato al successo oltre la scuola; uno così avrebbe ballato con me affabilmente e con condiscendenza, senza per questo farmi sentire meglio. Ad ogni modo, speravo che non troppa gente avesse assistito alla scena. Detestavo che la gente vedesse. Cominciai a mordicchiarmi il pollice.
Quando la musica tacque raggiunsi lo sciame di ragazze in fondo alla palestra. Fa’ finta che non sia successo nulla, dissi a me stessa. Fa’ finta che tutto cominci ora.
Il gruppo ricominciò a suonare. Ci fu un rimescolio nella folla dal nostro lato della pista. Le file si assottigliarono rapidamente; i ragazzi arrivavano e invitavano le ragazze a ballare. Lonnie fu invitata. L’altra ragazza che mi stava a fianco fu invitata. Nessuno invitò me. Mi venne in mente un articolo di una rivista che Lonnie ed io avevamo letto, che diceva Siate allegre! Fate vedere ai ragazzi che vi brillano gli occhi, fate udire le vostre risate! Semplice, ovvio, ma quante ragazze se ne dimenticano! Era vero, me n’ero dimenticata. Avevo le sopracciglia corrugate per la tensione, dovevo apparire brutta e spaventata. Respirai a fondo e cercai di assumere un’espressione rilassata. Sorrisi. Ma mi sentivo ridicola, lì a sorridere al muro e mi accorgevo che le ragazze sulla pista da ballo, le ragazze più ricercate, non sorridevano; molte avevano un’espressione sonnolenta, immusonita e non sorridevano mai.
Le ragazze continuavano ad andare a ballare. Alcune, disperate, ballavano tra loro, ma la maggior parte ballava con i ragazzi.
Ragazze grasse, ragazze piene di brufoli, una ragazza povera che non possedeva un vestito buono ed era venuta al ballo in gonna e maglione; tutte venivano invitate, tutte andavano a ballare. Perché loro e non io? Perché chiunque altro e non io? Io ho un vestito di velluto rosso, mi sono arricciata i capelli, mi sono deodorata e profumata con acqua di Colonia. Prega, pensai. Non potevo chiudere gli occhi, ma continuavo a ripetere mentalmente, ti prego, ti prego, incrociando le dita dietro la schiena in un segno molto più potente di quello della croce, lo stesso segno segreto cui Lonnie ed io ricorrevamo per non essere chiamate alla lavagna nell’ora di matematica.
Non funzionava. Ciò che avevo temuto si stava avverando. Sarei stata lasciata in disparte. C’era un qualcosa di misterioso che non andava in me, qualcosa a cui non si poteva porre rimedio, come l’alito cattivo, come i brufoli, e tutti lo sapevano, come lo sapevo io: l’avevo sempre saputo. Ma fino a quel momento non l’avevo saputo con sicurezza, avevo sperato di sbagliarmi. La certezza montò in me come un’ondata di nausea. Mi affrettai verso i bagni, lasciandomi alle spalle una o due ragazze che nessuno aveva invitato a ballare, e andai a nascondermi in un gabinetto.
Rimasi lì. Tra un ballo e l’altro le ragazze andavano e venivano rapidamente dal bagno. C’erano parecchi gabinetti: nessuna si accorse che il mio era sempre occupato. Durante i balli, ascoltavo la musica che mi piaceva ma in cui non avevo più parte, perché non avevo alcuna intenzione di tentare ancora.
Volevo solo rimanere lì nascosta, uscire senza vedere nessuno, andarmene a casa.
Ad un certo punto, dopo che la musica era ricominciata, qualcuno rimase indietro. Fece scorrere l’acqua a lungo, si lavò le mani con calma, si pettinò. Avrebbe trovato strano se fossi rimasta là dentro ancora a lungo. Era meglio uscire e lavarsi le mani; nel frattempo, forse, lei se ne sarebbe andata.
Era Mary Fortune. La conoscevo di nome, perché era una dirigente della Società atletica femminile, era sull’albo d’onore ed era sempre impegnata a organizzare eventi vari. Aveva qualcosa a che fare anche con l’organizzazione del ballo; era venuta in giro per le classi alla ricerca di volontari per decorare la palestra. Faceva la terza o la quarta.
« È bello fresco, qui dentro » disse. « Sono venuta a rinfrescarmi un po’. Mi è venuto un caldo… »
Quando ebbi finito di lavarmi le mani si stava ancora pettinando. « Ti piace il gruppo? » chiese.
« Abbastanza. » Non sapevo che cosa dire. Ero sorpresa che una ragazza più grande si mettesse a chiacchierare con me.
« A me no. Non lo sopporto. Detesto ballare quando non mi piace il gruppo. Sentili, non sanno che cosa sia il ritmo. Per ballare così, preferisco quasi non ballare. »
Cominciai a pettinarmi. Lei si appoggiò al lavabo, osservandomi. « Non ho voglia di ballare ma non ho neppure una gran voglia di rimanere qui dentro. Andiamo a fumarci una sigaretta. »
« Dove? »
« Vieni, ti faccio vedere. »
In fondo ai bagni c’era una porta. Non era chiusa a chiave; conduceva in uno stanzino buio pieno di secchi e strofinacci. Mi chiese di tenere la porta aperta per fare luce mentre cercava la maniglia di un’altra porta. Questa seconda porta si apriva sulla completa oscurità.
«Non posso accendere la luce, altrimenti qualcuno potrebbe vederla » disse. « È la stanza del bidello. » Pensai che gli atleti sembravano sempre saperne più degli altri sulla scuola in quanto edificio; sapevano dove venivano custodite le cose e li si vedeva sempre uscire da porte proibite con un’aria spavalda e assorta. « Guarda dove metti i piedi » disse. « Laggiù ci sono delle scale che portano ad uno sgabuzzino al secondo piano. La porta in cima è chiusa a chiave, ma c’è una specie di divisorio tra le scale e la stanza. Così, se ci sediamo sui gradini, anche se per caso qualcuno dovesse entrare qui dentro non ci vedrebbe. »
« E l’odore di funo? » chiesi.
«Oh, be’… Bisogna vivere pericolosamente. »
Sulle scale c’era una finestra alta da cui ci giungeva un po’ di luce. Mary Fortune aveva in borsetta sigarette e fiammiferi. Non avevo mai fumato prima, se non le sigarette che Lonnie ed io ci facevamo da sole con le cartine ed il tabacco rubati a suo padre, che si aprivano sempre nel mezzo; queste erano molto meglio.
« Guarda, 1’unico motivo per cui sono venuta stasera, » disse Mary Fortune, « è che sono responsabile delle decorazione e volevo vedere che effetto facevano una volta arrivata la gente e tutto quanto. Altrimenti perché prendersi la briga di venire? Non mi interessa correre dietro ai ragazzi. »
Alla luce dell’alta finestra riuscivo a distinguere il suo viso allungato, sprezzante, la sua pelle scura butterata dall’acne, gli incisivi accavallati, che le davano un’aria adulta ed autorevole.
« La maggior parte delle ragazze non pensa ad altro, l’hai notato? In questa scuola c’è la più alta concentrazione di ragazze che corrono dietro ai maschi. »
Le ero grata per l’attenzione, la compagnia e la sigaretta. Dissi che anch’io la pensavo così.
« Come questo pomeriggio. Questo pomeriggio stavo cercando di far sì che appendessero le campane e le altre cianfrusaglie e loro non facevano altro che salire sulle scale e fare le sceme con i ragazzi. Non gliene importava nulla delle decorazioni. Era solo una scusa. Fare le sceme con i ragazzi è l’unico scopo che hanno nella vita. Per me sono delle idiote. »
Parlammo degli insegnanti, delle cose di scuola. Disse che avrebbe voluto fare l’insegnante di educazione fisica e che per questo sarebbe dovuta andare all’università, ma i suoi genitori non avevano abbastanza soldi. Disse che aveva intenzione di lavorare per pagarsi gli studi, voleva essere indipendente, Comunque, avrebbe lavorato nella caffetteria e d’estate in qualche fattoria, magari raccogliendo tabacco. Ascoltandola, sentii che la fase acuta della mia crisi d’infelicità stava passando. Ecco una ragazza che aveva subito la mia stessa sconfitta – me ne rendevo conto – ma che era piena di energie e rispetto per se stessa. Aveva pensato ad altre cose da fare. Avrebbe raccolto tabacco.
Rimanemmo lì a parlare e fumare durante tutta la lunga pausa di riposo del gruppo, mentre in palestra venivano distribuiti caffè e ciambelle. Quando la musica ricominciò Mary disse: « Senti, dobbiamo starcene qui ancora molto? Prendiamo i cappotti e andiamocene. Possiamo andare da Lee a berci una cioccolata calda e parlare sedute comodamente, perché no?»
Attraversammo la stanza del bidello a tentoni, portandoci dietro i mozziconi delle sigarette e la cenere. Arrivate nello stanzino delle scope accostammo l’orecchio alla porta per sincerarci che nei bagni non ci fosse nessuno. Tornammo alla luce e gettammo la cenere nel gabinetto. Per arrivare al guardaroba, che era oltre la porta esterna, dovevamo uscire e attraversare la pista da ballo.
Proprio allora, stava iniziando un nuovo ballo. « Gira intorno al bordo della pista » disse Mary. « Non ci vedrà nessuno. »
La seguii. Non guardai nessuno. Non cercai Lonnie. Lonnie probabilmente non sarebbe stata più mia amica, non quanto prima, almeno. Lonnie era una di quelle che correvano dietro ai ragazzi, come avrebbe detto Mary.
Scoprii di non essere così spaventata, ora che mi ero decisa a lasciare il ballo. Non aspettavo più che qualcuno mi scegliesse, avevo i miei progetti. Non c’era più bisogno che sorridessi o incrociassi le dita. Non m’importava più. Stavo andandomene a bere una cioccolata calda, con la mia amica.
Un ragazzo mi disse qualcosa. Era di fronte a me. Pensai che mi stesse dicendo che mi era caduto qualcosa, o che non si poteva andare da quella parte, o che il guardaroba era chiuso a chiave. Non capii che mi stava chiedendo di ballare finché non lo ripeté per la seconda volta. Era Raymond Bolting, un ragazzo della mia classe a cui non avevo mai rivolto la parola. Pensò che avessi accettato. Mi appoggiò una mano sulla vita e quasi senza volere mi misi a ballare.
Ci spostammo al centro della pista. Stavo ballando. Le mie gambe si erano dimenticate di tremare e le mie mani di sudare. Stavo ballando con un ragazzo che mi aveva invitato. Nessuno gli aveva detto di farlo, non era obbligato, mi aveva semplicemente invitato. Era davvero possibile, potevo crederci, non c’era nulla che non andasse in me, dopo tutto?
Pensai che avrei dovuto dirgli che c’era un malinteso, che stavo andando via, a bere una cioccolata calda con una mia amica. Ma non dissi nulla. Il mio viso stava subendo lievi mutamenti, assumendo senza sforzo quella espressione grave e distratta di quelle che venivano scelte, di quelle che ballavano. Fu questo il viso che Mary Fortune vide quando guardò fuori dalla porta del guardaroba, la sciarpa già avvolta intorno alla testa. Le feci un debole cenno con la mano appoggiata alla spalla del ragazzo, un cenno che significava che mi scusavo, che non sapevo che cosa fosse successo e anche che era inutile che mi aspettasse. Poi voltai la testa e quando guardai ancora non c’era più.
Raymond Bolting mi accompagnò a casa, mentre Harold Simons accompagnava Lonnie. I ragazzi ebbero una discussione su una partita di hokey, che Lonnie ed io non riuscivamo a seguire. Quando poi ci separammo, Raymond continuò con me la stessa conversazione; non sembrava rendersi conto che stava parlando con me, ora. Un paio di volte dissi, « Be’, non so, non ho visto la partita » ma dopo un po’ decisi di limitarmi ad annuire: non sembrava fosse necessario altro.
Raymond disse anche un’altra cosa: « Non pensavo che abitassi così lontano ». Tirò su col naso. Anche a me colava un pochino il naso a causa del freddo e mi frugai in tasca, tra le carte di caramella, alla ricerca di un fazzolettino di carta spiegazzato. Non sapevo se dovevo offrirglielo o no, ma tirava su col naso così rumorosamente che alla fine gli dissi: « Ho solo questo, probabilmente non è neppure pulito, dev’essere macchiato d’inchiostro. Ma se lo divido a metà ce n’è un pezzetto per tutti e due ».
« Grazie » disse. « Ne ho sicuramente bisogno. »
Era stato un bene, pensai, che gliel’avessi offerto, perché arrivati al cancello, quando gli dissi, « Be’, buona notte », mi rispose, « Oh, già, buona notte » e poi si chinò verso di me e mi baciò, brevemente, con l’aria di uno che sa qual è il suo dovere, sull’angolo della bocca. Poi se ne tornò in città, senza sapere che mi aveva salvato, che mi aveva riportato dal territorio di Mary Fortune nel mondo normale. »
Girai intorno alla casa per raggiungere la porta sul retro, pensando, sono stata a un ballo e un ragazzo mi ha accompagnata a casa e mi ha baciata. Era tutto vero. La mia vita era possibile. Passai davanti alla finestra della cucina e vidi mia madre. Era seduta con i piedi sullo sportello aperto del forno e beveva del tè da una tazza senza piattino. Stava semplicemente lì seduta ad aspettare che tornassi a casa e le raccontassi tutto quello che era successo. E io non l’avrei fatto, non l’avrei mai fatto. Ma quando vidi la cucina immersa nell’attesa e mia madre con il suo chimono a disegni cachemire stinto e sfilacciato, il viso assonnato ma pieno di tenace aspettativa, capii che avevo un misterioso e opprimente obbligo di essere felice, e che per poco non avevo fallito, e che avrei sempre rischiato di fallire, ogni volta, lei non l’avrebbe mai saputo.











 di
di 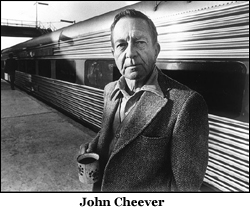 Leggere questo racconto come il declino del protagonista che passa dall’apice della sua maturità al decadimento è fin troppo semplice, anche se resta comunque interessante analizzare ciascuno dei simboli utilizzati da John Cheever, comprese le citazioni interne e gli omaggi che offre alla sua letteratura preferita (soprattutto Dante e Kafka, con qualche accenno a Hawthorne).
Leggere questo racconto come il declino del protagonista che passa dall’apice della sua maturità al decadimento è fin troppo semplice, anche se resta comunque interessante analizzare ciascuno dei simboli utilizzati da John Cheever, comprese le citazioni interne e gli omaggi che offre alla sua letteratura preferita (soprattutto Dante e Kafka, con qualche accenno a Hawthorne).
/image%2F1466313%2F20220330%2Fob_cbdff0_2753consacrazione-san-pietro.jpg)